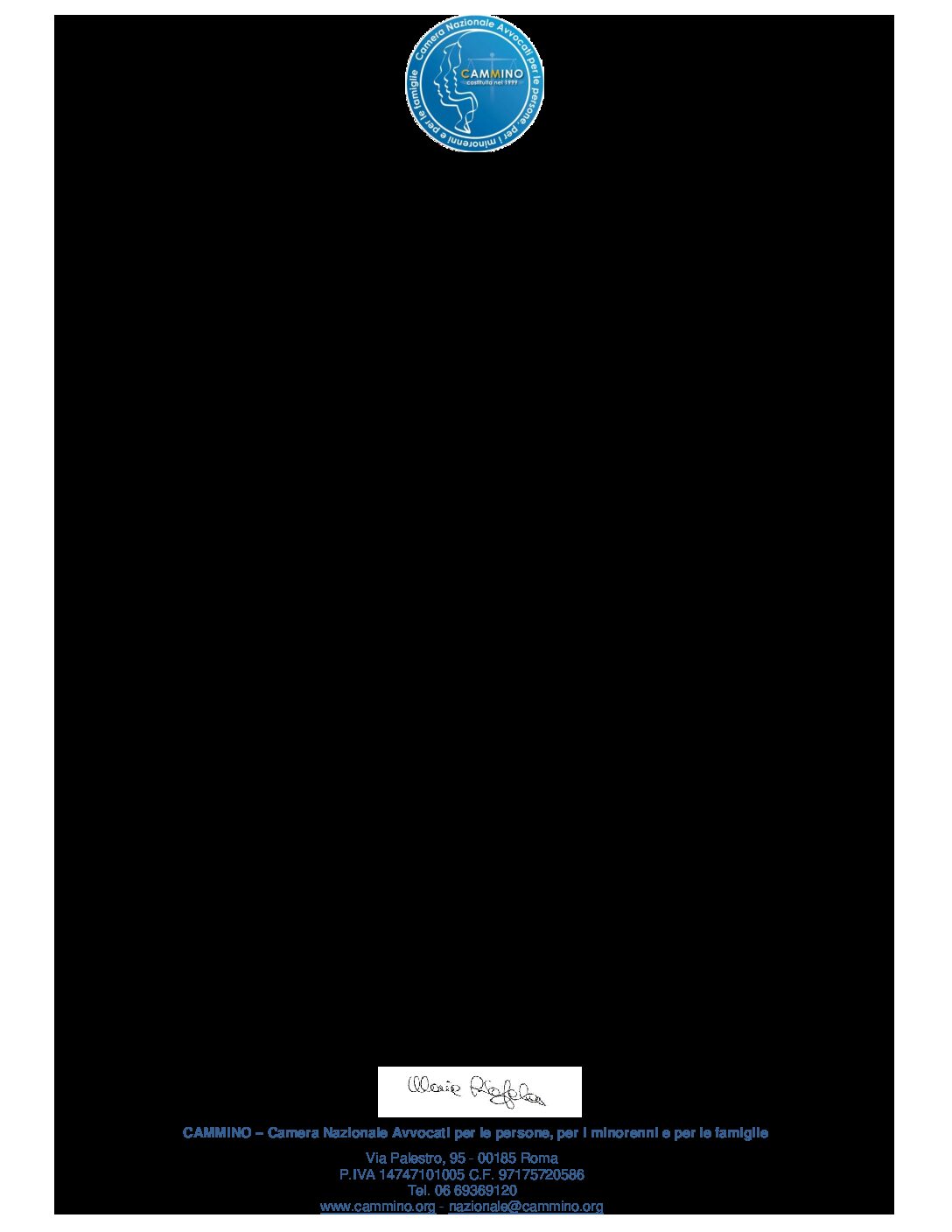Lo scorso 3 dicembre è stata celebrata la “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1981 per promuovere i diritti e il benessere di tutti i disabili, i quali costituiscono il 15% della popolazione mondiale (Rapporto Mondiale sulla Disabilità, OMS-Banca mondiale, 2011) e il 5,2% della popolazione italiana (Rapporto Istat “Conoscere il mondo della disabilità”, 2019).
Il riconoscimento dei diritti di tale categoria di persone ha trovato il suo apice con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (Convention on the rights of persons with disabilities – CRPD) adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con la legge n. 18 del 2009 (al 2019, sono 163 gli Stati firmatari della Convenzione). Tale strumento normativo, oltre a costituire una svolta a livello internazionale dal punto di vista giuridico, per via del riconoscimento esplicito di diritti soggettivi specifici in capo a queste persone, costituisce anche un’innovazione dal punto di vista culturale, poiché introduce una nuova concezione della “disabilità” così come delineata dall’OMS nel 2001, tramite il documento ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health. Questa condizione, infatti, adesso viene definita in base ad un nuovo modello di matrice “bio-psico-sociale”, che coglie in maniera integrale la completa fenomenologia umana, ponendo sullo stesso piano gli aspetti di natura clinica (su cui si basava la precedente definizione OMS di disabilità) e gli aspetti di interazione sociale, conferendo opportuno valore a tutti i contesti relazionali, pubblici e privati, in cui si estrinseca l’attività umana di un soggetto portatore di disabilità. Non più una “malattia” da sopportare all’interno del mero contesto familiare ma una condizione che necessita di essere riconosciuta, accolta, integrata (rectius inclusa) e valorizzata dall’intera società. Letta con gli occhi di un giurista, pertanto, la CRPD segna il passaggio da una visione giusprivatistica ad una visione giuspubblicistica della disabilità, con tutto ciò che consegue in termini di azioni “positive” richieste ai singoli Stati.
A livello macro-sistemico, grande impegno è già stato profuso, tramite l’invito all’azione da parte della comunità internazionale: nel 2012, infatti, le Nazioni Unite, stabilendo i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile a sostegno della propria Agenda 2030, hanno incluso anche quello di “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi [oltre che] sicuri, duraturi e sostenibili” (obiettivo n. 11). Inoltre, sul piano sovranazionale, l’articolo 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce che “L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”. E sempre la CRDP, tra le altre cose, all’art. 9 co.2 lett. (g). afferma che “Gli Stati Parti […] dovranno prendere appropriate misure per: […] promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet”.
Infatti, se l’inclusione deve avvenire all’interno del contesto sociale, l’avvento dell’uso massiccio delle tecnologie dovrebbe agevolare questo processo, in modo da rendere i contesi urbani luoghi di reale “inclusive smart living”. Ma la vera domanda è: «How can digital solutions advance, rather than impede, inclusion?» (Report by Deloitte Center for Governament Insight, 2019). Infatti, mentre l’urbanizzazione ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di milioni di persone in tutto il mondo, esistono disparità economiche e sociali croniche tra gli abitanti delle città: nei Paesi in via di sviluppo, un residente urbano su tre vive ancora nei bassifondi con servizi di base inadeguati; inoltre, in tutti i Paesi che fanno parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il divario di reddito tra il 10% più ricco e il 10% più povero della popolazione è aumentato esponenzialmente negli ultimi 25 anni. In questo contesto, le persone maggiormente vulnerabili ed in particolare quelle caratterizzate da condizioni di disabilità non hanno potuto condividere a sufficienza la prosperità derivante della rivitalizzazione urbana. Tali disparità crescenti hanno ricollocato il concetto di inclusione in primo piano in relazione allo sviluppo urbano: fornire a tutti i residenti un uguale accesso ai servizi della città, consentire loro di partecipare al processo decisionale comunale e beneficiare della crescita economica della città sono diventate priorità assolute di tutte le politiche UE.
Pertanto, tramite l’azione pubblica, il fine ultimo di tali politiche “smart” è rappresentato dallo sviluppo umano integrale dei cittadini, ivi compresi i soggetti disabili, che hanno bisogno di vivere attivamente la città ed al contempo di collaborare attivamente alla sua crescita, in un’ottica di sostenibilità ambientale e umana.
CAMMINO, dal canto suo, è da oltre vent’anni impegnata per la tutela dei soggetti vulnerabili ed ha sempre mostrato una certa sensibilità per le dinamiche relative alla disabilità (solo per citare gli ultimi eventi, lo scorso 4 ottobre si è tenuto a Monza un Convegno dal titolo “Tutela Giuridica e inclusione scolastica di alunni, studenti e adulti con disprassia”, organizzato da CAMMINO e AD&F – Associazione Disprassia e Famiglie – ed anche il prossimo 17 dicembre si terrà a Roma un seminario dal titolo “Internet e fragilità”). Tali iniziative si inseriscono all’interno di quel processo che prevede la necessaria ricognizione concettuale relativa ai contenuti delle diverse normative (nonché delle sempre crescenti pronunce giurisprudenziali) esistenti in tema di tutela della disabilità, a livello internazionale, sovranazionale, nazionale, regionale e locale: il tentativo è quello di cogliere gli spunti positivi e le criticità esistenti e di verificare l’esistenza di buone prassi da implementare e sistematizzare, anche tramite l’utilizzo di adeguate tecnologie dell’informazione e della comunicazione (I.C.T), l’utilizzo di banche dati giuridiche, nonché di database tematici in grado di ricevere informazioni da enti locali, autorità di pubblica sicurezza, associazioni, ETS accreditati, e che al contempo garantiscano il pieno rispetto del diritto alla privacy, così come richiesto dal Regolamento UE 2016/679 (a Londra, ad esempio, una joint venture tra Google e la Royal London Society for Blind People riesce ad aiutare i soggetti non vedenti a navigare nella rete di trasporto della città, utilizzando beacon Bluetooth al fine di fornire rapide e aggiornate istruzioni audio, tramite un’App per smartphone (Report Deloitte, 2019).
In conclusione, la disabilità si offre come un prezioso connettore fra tre diverse realtà che faticano a trovare un linguaggio comune nell’epoca contemporanea, ovvero la tecnologia, il diritto e la politica, riconsegnando a ciascuna di esse il proprio ruolo originario: infatti, tramite quello che non è un fine ma un semplice strumento (l’uso delle nuove tecnologie), è possibile agevolare la tutela di una condizione esistenziale vulnerabile (tramite il diritto), al fine di prestare un servizio concreto alla realizzazione del bene comune (senso ultimo della politica).
Avv. Vincenzo Lorubbio (Ph.D)
Ricercatore TD(a) in Diritto pubblico comparato presso l’Università del Salento
Componente Consiglio Direttivo di Cammino, responsabile Area disabilità e smart cities